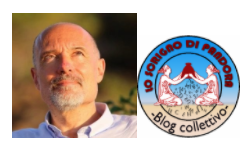
“Ciao, sono triste, mi è ricominciata l’angoscia, non sto bene: vieni a fare due chiacchiere da me?”
“Certo. Domani?”
“Sì. Vieni alle quattro e mezza”
“Va bene”.
L’indomani alle quattro e venti messaggio su Facebook. Per favore chiamami a quest’altro numero, con il mio normale ho casini”.
Dopo un minuto chiamo.
“Sì, sono incazzata nera, mio figlio ha spaccato il mio telefono, non funziona più”.
“E quest’altro dove ti sto chiamando?”
“Quegli stronzi me lo hanno bloccato”.
“Ma chi? Quali stronzi?”
“Quelli dell’abbonamento. Ho sforato il tetto e da mesi mi hanno bloccato”.
“Ma guarda che puoi mettere la Sim del tuo telefono su quest’altro”.
“No no, sono in abbonamento”.
“Ma che vuol dire? Puoi spostare la tua Sim dove vuoi. Così puoi usare il tuo numero ‘normale’, e chiamare”.
“Ok, ma se vuoi usare il tuo numero lo stesso e non puoi aprire l’iPhone, prendi un telefono vecchio, o comprane uno dai pakistani, o alla Coop: diciassette euro, costano come tre pizze e due chili di arance. L’ho comprato anche io per mia mamma, diciassette euro. Comunque, ci vediamo tra poco”.
Nella conversazione sono passati venti minuti.
Parto, ma sto in periferia e ci vuole mezz’ora per arrivare. Sono le cinque, non le quattro e mezza. Perché alle quattro e mezza eravamo al telefono.
Suono.
Non risponde nessuno.
Risuono.
Non risponde nessuno.
Chiamo al telefono dell’iPhone, quello buono, quello dove può rispondere.
Non risponde nessuno.
Ok. Mi faccio un giretto.
Sono sui Lungarni quando, dieci minuti dopo, squilla il telefono.
“Dove sei?”
“Ero sotto casa tua, ora sono sui Lungarni. Ho suonato due volte”.
“Ah, non sentivamo. E non sentivo il telefono”.
“D’accordo. Vengo”.
Due minuti dopo sono lì. Suono.
Di nuovo nessuno risponde. Però un africano sta entrando. Ha la chiave. Allora lo guardo, per sapere se posso entrare con lui. Gli sembra normale. Entro. Mentre entriamo, scatta il bizz dell’apriporta.
E’ una casa vecchia, come lo sono le case del centro. Scalini stretti, e dopo il primo pianerottolo si divide in due. Destra e sinistra. Dove vado?
Sento rumori a destra, vado di là.
Mentre salgo le scale, c’è lei che scende. Con un bimbo, tutto vestito, con una custodia per violino sulle spalle e una specie di cartella. Ha l’aria seria seria, il bimbo.
Lei è tutta di corsa, vestita con il cappotto, gli stivali e i guanti. Ci incrociamo, e continua a scendere.
“Ma… vai via?”
“Sì, devo portare il bimbo a Santa Brigida dai nonni. Aspettavo che tu suonassi per uscire”
“E… e io?”
“Sali: c’è mio figlio”
“Che non conosco, e che ha otto anni. Io sono venuto per vedere te”
“E vabbè, poi torno”
“Poi torni? Ma stai andando fuori città, un’ora a andare e una a tornare, per non dire che oggi c’è la partita e il traffico sarà impazzito.
E subito dopo, mi hai detto, devi uscire per una cena”
“Ma ci metto pochissimo ad andare e tornare!”
“E io sto qui con un bambino di otto anni che non conosco, per vederti arrivare trafelata per andare alla cena. Ok, no, devo andare”
Siamo fuori, nella piazza antica, secoli di storia guardano due adulti e un bambino che sembra pronto per aspettare il pulmino della scuola.
“Beh, io vado a prendere la macchina, aspettami qui con Guido”
Guido ha la faccia rassegnata.
“Bello il violino”, gli dico. “Anche io ne avevo uno. E’ difficile da suonare”.
Lui annuisce, obbediente. Se gli avessi detto “Oggi Totti non gioca”, o “Si è spezzata la mano del David di Donatello”, avrebbe annuito con lo stesso sguardo serio e rassegnato.
Firenze, in compenso, a quell’ora di crepuscolo d’inverno è bellissima. I Lungarni sono luminosi, il rosso nel cielo a valle, l’azzurro a monte. Il giallo delle case. L’acqua. Non ci passeggio quasi mai, in questa città così bella.
L’aria è fredda d’inverno, ma ha già qualcosa di speranza, dentro. Fino a che c’è questa luce, mi sento ricco. Posso scegliere persino dove andare: Ponte Vecchio, oppure all’esterno, verso la luce, lì’ dove il fiume si apre, i ponti sembrano più larghi, o forse lo sono.
Nuvole rosa, e i palazzi sembrano una piccola Venezia sul Canal grande. Uno diverso dall’altro, su quell’acqua fermissima, senza caos di vaporetti.
Mi dispiace, bimbo di otto anni che non ti conosco. Avrei dovuto fare il baby sitter per te. Ma io non sono stato capace di farlo, un figlio, non ne ho avuto il coraggio, o la fortuna. E non saprei come fare a parlarti, a calmarti, a dirti che va tutto bene. Stai crescendo da solo, con tua madre che è sempre via, e tuo papà non lo so, dove sia. E io non posso aiutarti.
Tuo fratello adesso è in macchina, verso la campagna, e io sono qui, con due turisti giapponesi di mezza età che mi incrociano, e una che fa jogging e mi arriva alle spalle, e mi sorpassa in un attimo.
Io che non so che cosa conti veramente nella vita, che cosa dovrei fare, se dovrei scrivere, o vivere, o fregarmene di tutto, o cercare di cogliere il senso di ogni cosa, o osservare come se fossi una macchina fotografica che fotografa i sentimenti, che registra il rumore delle emozioni.
- Ci pensa il cielo - 23 Aprile 2024
- La rosa inglese - 23 Aprile 2024
- Gino Severini, La moglie e la figlia dell’artista - 23 Aprile 2024