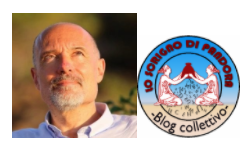
Ha la voce ridente, Enzo G. Castellari, regista “cult” del cinema di genere italiano, idolatrato da Quentin Tarantino, che si è ispirato a lui per il film “Bastardi senza gloria”: per poi invitarlo a Los Angeles, e fargli vivere due settimane di sarabanda fra amici registi e attori.
Ha la voce ridente, nonostante gli ottantadue anni e l’isolamento in casa. “Certo che ho paura, per me e per mia moglie: lei è fragile, se arriva il covid dentro casa non so come andrebbe a finire”.
E allora, guarda Roma dal terrazzo di casa. E ha un po’ di tempo per sciorinare i ricordi di una carriera lunga, densa, e che non intende affatto come conclusa.
Titoli da uomini duri, i suoi: “Pochi dollari per Django”, “Sette Winchester per un massacro”, “Vado, l’ammazzo e torno”, “La polizia incrimina, la legge assolve”, “Il cittadino si ribella”, “Quel maledetto treno blindato”. Non c’erano dubbi, già dal titolo.
Si sparava, si combatteva, in storie di duelli, di vendette, di coraggio. O in western crepuscolari come “Keoma”, forse il suo film più personale, più sentito. Ma in genere, il suo credo era uno solo: azione!
Enzo, scattiamo idealmente una serie di fotografie di volti amati con cui ha lavorato. Cominciamo dal suo attore-feticcio, quello con cui ha lavorato di più: Franco Nero.
“E pensare che non doveva esserci lui, nei miei film. Quando iniziammo il genere del ‘poliziottesco’, con ‘La polizia incrimina, la legge assolve’, per il nostro commissario di ferro cercavo un volto internazionale, conosciuto in tutto il mondo. E pensai a Mark Spitz”.
Ma non era un campione di nuoto?
“Esattamente. L’uomo che aveva vinto sette medaglie d’oro alle Olimpiadi del 1972, un fenomeno mai visto nello sport. Era anche un bel tipo, con un paio di baffoni da duro. E si era ritirato dallo sport, dopo quelle vittorie.
Provammo lui, ma rifiutò. E allora mi ricordai che la mia più cara amica era la parrucchiera personale di Franco. Le chiesi di aiutarmi”.
Come fu il vostro incontro?
“Franco era – ed è – di pochissime parole. Bofonchiò qualcosa. Da quelle poche parole, capii quanto amasse il cinema. Si fece dare la sceneggiatura. Da allora, non so quante volte abbiamo lavorato insieme”.
Ci furono mai momenti di rischio, nei film che avete girato?
“Franco usava pochissimo le controfigure, tutte le corse e le scene ‘fisiche’ le faceva lui.
E una volta rischiò di morire. Ne ‘Il cittadino si ribella’ veniva inseguito da una Mustang in un terreno accidentato. Franco correva all’impazzata, la macchina dietro: a un certo punto si sloga una caviglia, cade e l’auto gli va addosso: lui salta sul cofano e continua a correre. Ma poteva finire malissimo”.
Un altro mito. Bud Spencer. Con lui girò sei episodi della serie “Detective Extralarge”, nel 1991, a Miami. Cosa ricorda?
“Ricordo un attore colto, preparato, e anche modesto. Non si riteneva un grande attore: ‘sono un personaggio, non un attore’, diceva di sé. E invece aveva presenza, carisma, simpatia, energia, si faceva amare. Che vuoi di più?
A Miami lui aveva preso una bella casa, si sentiva bene a girare lì. E il cibo, è vero che non se lo faceva mancare: andammo a un ristorante strafamoso per le polpette. Io credo che quella sera se ne sia mangiate una cinquantina. Ma forse mi sbaglio: era qualcuna di più”.
Il suo mito fra i registi?
“Sam Peckinpah, quello del ‘Mucchio selvaggio’ e di ‘Cane di paglia’. Quando venne a Roma per girare un film con Fabio Testi, feci di tutto per incontrarlo. Andai, emozionatissimo, sperando di fare una lunga chiacchierata con lui. Ma lui era ubriaco fradicio, e strafatto di chissà che cosa. Non era possibile più comunicare con lui. Che amarezza”.
Lei è stato sempre considerato un regista di film “di genere”. Ma amava anche i maestri del cinema d’autore?
“Sembrerà impossibile, ma fra i miei registi preferiti c’è Bergman. In ‘Keoma’, la scena in cui appare la Morte è ripresa dal ‘Settimo sigillo’ di Bergman, e i flashback idem”.
Lei ha girato tanti western all’italiana: duri, scabri, spettacolari. Qual è il fascino del genere western, per lei?
“Il western è bello perché è semplice: ci sono buoni e cattivi, eroi e vigliacchi. Grandi spazi e cavalli. Poi, basta cambiare i cavalli con le Giulia Alfa Romeo, e hai il poliziottesco!”. Ride.
Lei ha una formazione da studente di Belle arti, e ha sempre disegnato minuziosamente i suoi film, prima di girarli. Direbbe di sé che è un regista molto tecnico?
“Beh, direi un’altra cosa: che nei miei film, aspetto sempre il momento in cui arriva il problema. Una scena difficile da girare, un movimento della macchina da presa che sembra impossibile. Tecnicamente, per me, quello è un regalo: mi piace molto trovare soluzioni”.
Qual è stata la sua scuola?
“I set dei film di mio padre, Marino Girolami. Ne ho fatti tanti: lo seguivo sul set, e finite le riprese li montavo tutti io, e quella è stata una scuola straordinaria”.
Lei ha fatto anche molto pugilato. Ha mai usato questo suo passato da pugile?
“Un giorno stavano girando ‘Rocco e i suoi fratelli’. Era un film in cui una palestra di pugilato era al centro della scena. Io passai dal set e dissi: vi prego, fatemi ‘fare i guanti’ con Alain Delon! Ma me li fecero fare con l’allenatore di Delon e Salvadori, Aristide Dal Piaz, campione italiano di pugilato. Mi tirò un pugno d’incontro che ancora me lo ricordo!”.
Politicamente, la hanno sempre etichettata come regista “macho”, e di destra. Quanto c’è di vero?
“Le dico solo una cosa: io amavo moltissimo mio nonno Terenzio, che aveva dietro la porta di casa una enorme foto di Giacomo Matteotti, il segretario del Partito socialista che fu massacrato dai fascisti nel 1922.
Beh, per via di quel manifesto, mio nonno fu preso da una banda di fascisti, alla fine della Seconda guerra mondiale, e picchiato fino alla morte. Posso essere fascista io? I miei film dicono che, se vieni massacrato, umiliato, minacciato, alla fine ti ribelli. Ma sono stato applaudito anche nelle Case del popolo”.
Lei però, negli anni ’70, non era propriamente un pacifista. Girava con una pistola.
“In quegli anni, purtroppo, era piuttosto comune Quando abbracciavi un amico, spesso sentivi qualcosa di ingombrante, nella giacca, sotto l’ascella. Era la pistola.
Io, nella megalomania del giovane regista di successo, mi ero comprato una bella Rolls Royce. Una sera tardi, in un vicolo, trovo tre giovanotti seduti sopra, con aria di sfida. ‘Aoh, c’hai a Rolls!’ e ridono. ‘Sì, però ho anche questa’, e tiro fuori la pistola. ‘Aoh! E’ arrivato Bufalo Bill! Annamose, va’…’, e se ne vanno via.
Ma senza pistola, non so come sarebbe andata a finire. Un’altra volta trovo uno che la stava rubando. Gli ho puntato la pistola alla nuca. È scappato, facendosela addosso. Ma non metaforicamente”.
Gli anni ’70 lei li ha raccontati in maniera molto violenta, nei suoi film.
“Erano anni violenti. Quanto più cruenta inventavi una scena, tanto era più ‘gusta’. Poi la cronaca, il giorno dopo, ti diceva che eri stato persino timido”.
Erano anche anni di eccessi e di droghe. Lei come li ha vissuti?
“Sembrerà ridicolo, ma ho incrociato le droghe solo una volta. A Hollywood, alla festa di un attore americano. C’era una ragazzona che distribuiva dolcetti: boni, boni. Ne mangiai una cifra, senza capire che erano dolcetti all’hashish. Non riuscivo ad alzarmi in piedi, ero diventato catatonico: mia moglie mi trascinò quasi per i piedi fino alla macchina”.
Tarantino è uno dei suoi fans più sfegatati. Che cosa è accaduto quando vi siete incontrati?
“E’ stato imbarazzante: Quentin Tarantino che mi urla: ‘Maestro!’ e mi abbraccia. E poi mi invita a Los Angeles: all’arrivo all’aeroporto c’è una Limousine per me, e poi una proiezione di gala del mio film ‘Quel maledetto treno blindato’ con tutta Hollywood. I grandi che non avevo conosciuto mai, li ho conosciuti tutti quel giorno”.
L’attore hollywoodiano con cui avrebbe voluto lavorare?
“Quello con cui stavo per lavorare: Robert Redford. Ci conoscemmo negli anni ’70, a una festa a Los Angeles, per la proiezione del film ‘The Chase’ con Marlon Brando. Trovammo un terreno comune di conversazione, perché lui aveva studiato Belle arti a Firenze, era innamorato dell’arte italiana.
Quando dovevo fare ‘Sette Winchester, il mio primo film, mi ricordai di quel ragazzo americano, bellissimo, biondo. Sarebbe venuto a lavorare per 30mila dollari, una sciocchezza. Niente. Ma scelsero un altro, che all’epoca era famoso per una serie televisiva che era uscita anche in Italia. E addio Redford”.
Ha sfiorato altri divi hollywoodiani?
“Quando lavoravo con Carlo Ponti, bastava una sua telefonata e parlavo con Dustin Hoffman, con De Niro, con tutti. L’incontro più intenso è stato con Paul Newman. Volevo girare con lui un film, e andai a Los Angeles: mi ha invitato a casa sua, e sono stato tre giorni con lui, leggendo e commentando la sceneggiatura.
Stava nascendo una cosa bellissima, ma non siamo mai riusciti a organizzarla. Lui però non voleva 30mila dollari: ne voleva tre milioni!”.
A 82 anni, ha una presenza di spirito straordinaria. Ma come si tiene in forma?
“Non bevo, non fumo, sto molto attento al colesterolo. E la sera,a cena, mangio sempre salmone, possibilmente crudo. Lo vado a prendere giù, dal giapponese, e me lo porto a casa. Sono ghiottissimo di pesce, e mi sa che faccia bene.
Guardo Roma dal terrazzo, disegno e dipingo, e in fondo stare a casa non mi pesa. Mi pesa il dolore della gente, e l’ansia che ci prende tutti”.
Da www.quotidiano.net
- Ci pensa il cielo - 23 Aprile 2024
- La rosa inglese - 23 Aprile 2024
- Gino Severini, La moglie e la figlia dell’artista - 23 Aprile 2024