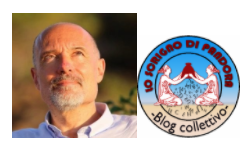
Era il 1983. Finiva l’autunno, finiva il periodo dei libri scolastici. Io avevo vent’anni. Lavoravo al reparto scolastico della libreria Marzocco, nel cuore di Firenze. Alla fine di ottobre, o forse a novembre, non ci fu più bisogno di noi.
E fu così che conobbi Orazio. Orazio dirigeva il reparto dei libri tascabili, lì alla Marzocco. “Vai ai self”, mi dissero. Il reparto dei “self”, cioè dei libri tascabili. Il self service. Che poi non era vero mai. Perché c’era sempre qualcuno che ti chiedeva “ma dov’è l’ultimo libro di Cassola?”, “dove trovo ‘Cime tempestose?’”, o “C’è una versione più economica di questo libro?”.
Una cassa, due lunghi corridoi pieni di libri, Oscar Mondadori, libretti Bur Rizzoli, libri bianchi di Einaudi. Tanta gente, sempre. Non solo ragazzi, ma adulti che amavano leggere, persone e non solo studenti. Gente che veniva a comprare un libro per scelta, per piacere, per crescere, per diventare migliore.
E in mezzo a questo traffico, Orazio. Occhiali da vista dalla montatura rettangolare, e golfini sempre di colori nitidi: azzurro, o rosso, o bordeaux. Sempre calmo, sempre gentile. Non me lo ricordo mai con una giacca, a pensarci adesso. Sempre quei golfini, sempre camicie di cotone, dentro lo scollo tondo del maglione.
Aveva un’eleganza sobria, pulita, ordinata. Mai la barba non fatta, mai i capelli fuori posto. Eppure non l’ho mai visto con la giacca, raramente anche con la cravatta.
Sui banchi dell’università, Mario Garriba mi insegnava che come ci vestiamo è un “segno”. Aveva preso l’idea da Roland Barthes, ma allora non lo sapevo ancora. Vestirsi è parlare, è comunicare, è dire chi siamo, come siamo, come ci rappresentiamo.
Orazio era pulito, limpido, semplice, onesto, lavoratore, calmo, sobrio, razionale, modesto. E diceva tutto questo già con i suoi golfini, con i suoi occhiali, di cui praticamente non ha cambiato mai la montatura.
Dovevo starci poche settimane, in quel reparto. Ci rimasi quasi un anno, passando le varie stagioni della libreria: il furore parossistico del Natale, quando dalla mattina alle otto di sera devi fare pacchetti, pacchetti, solo pacchetti, con il fiocco e l’etichetta adesiva col nome della libreria. Poi passa Natale, quella che per i librai è una guerra finisce alle 20 del 24 dicembre. E dopo Natale, comincia l’inverno degli inventari. È come contare morti e feriti, le truppe superstiti, i soldati che non sono caduti. Scrivi, uno per uno, tutti i libri che sono rimasti, e richiedi alla casa editrice tutti gli altri. Poi sono passate altre stagioni, e ogni volta dovevo finire di lavorare, e invece rimanevo lì.
Perché era Orazio che diceva al padrone della libreria di tenermi ancora una settimana, e poi ancora una.
Orazio era sempre gentile con i clienti, anche quando chiedevano cose assurde. Anche quando chiedevano “L’Amaro di Molière” o “Tre uomini in Burka”. Non si scomponeva mai. Neanche quando chiedevano “La moltitudine dei numeri dispari”, o “un libro che si chiama ‘Uno, qualcuno e… non mi ricordo l’ultimo’”. Non faceva mai una piega. Anche perché, lo capisco ora, c’è poco da vantarsi di avere avuto la fortuna di essere andati a scuola, di avere avuto la fortuna di studiare. E magari qualcun altro quella fortuna non l’aveva avuta, e cercava il libro per il figlio o la figlia, per fare qualcosa di buono per lui o per lei. Non c’è nessun uomo che possa guardare un altro uomo dal basso in alto.
Questa è una delle cose che mi ha insegnato Orazio. La sua calma no, non sono riuscito mai a impararla. Lui era un lord inglese, mai arrogante e mai schiavo di nessuno.
Orazio andava a casa in bicicletta, e io sentivo che era un uomo libero. Libero nel pensiero, libero nell’animo. Con lui, nei rari momenti in cui eravamo alla cassa, davanti all’ingresso, e non veniva nessuno a chiedere qualcosa, con lui parlavo di cinema e di letteratura. Perché lui aveva visto tutti i film, sapeva tutto di Truffaut e di Godard, di Fellini e di Antonioni, del free cinema inglese e delle commedie all’italiana. Michelangelo Antonioni.io ne ero affascinato, ero affascinato dalle sue geometrie, dal suo modo di toccare il mistero, con inquadrature, silenzi, sequenze dal significato incomprensibile. Orazio mi disse una frase che non ho dimenticato: “Antonioni usa i suoi attori come Morandi usa le bottiglie”. Le bottiglie dei quadri di Giorgio Morandi. Oggetti in uno spazio, uno spazio arido, senza vita.
Da allora, non ho smesso di amare Antonioni, ma ci ho sempre pensato, a quella frase. E a come per lui i personaggi di Antonioni avevano “problemi borghesi”. Io, a vent’anni, non sapevo molto dei problemi borghesi. Non sapevo che significava “problemi da ricchi”. Orazio voleva dire che la gente come noi non aveva il tempo, come Monica Vitti nel “Deserto rosso”, di dire: “mi fanno male i capelli”.
Non amava i tormenti mentali di Antonioni e dei suoi personaggi come bottiglie di Morandi. Amava, invece, tanto, i film francesi, conosceva autori che io, studente di cinema, non conoscevo ancora: Claude Sautet, per esempio. O certi piccoli film di Eric Rohmer.
“E com’è Parigi?” gli chiedevo, quando ancora non c’ero stato mai.
“Oh, Parigi adesso è una metropoli come ogni altra”, mi disse, senza enfasi, senza tristezza, senza obiezioni contro l’avanzata della modernità. “Parigi è la Defense, è un quartiere modernissimo di grattacieli. Non penserai mica che sia tutta fatta a stradine con i pittori e le ballerine?”.
Però, ha continuato ad amare il cinema francese, e forse anche Parigi.
Con Orazio parlavo dei libri che arrivavano. Parlammo di Andrea De Carlo, che allora era solo al secondo romanzo,”Uccelli da gabbia e da voliera”. Pubblicato da Einaudi, giovane, moderno nello stile. Sembrava lì il futuro. Orazio parlava anche di Flaubert, di Cechov, di Maupassant, di Tolstoj, ma sempre senza aver l’aria di saperla lunga, e quindi poi ti dimenticavi di quanti nomi fossero passati, nell’aria, da lui a te, come un virus buono, come qualcosa che poi sarebbe cresciuto dentro di te. La voglia di leggere, e di scrivere.
Quel Natale del 1983 passato a maneggiar libri, tutti compravano “Il nome della rosa”. Era uscita l’edizione tascabile, costava poco, e già quella rilegata era stata un successo. Ne arrivavano a centinaia, centinaia di copie dello stesso volume, pile immense di Nomi della rosa, grattacieli di Nomi della rosa, piramidi di Cheope di Nomi della rosa, e toccava a me metterli a posto. Tenerli in un magazzino provvisorio, su nel piccolo stanzino di sopra. Colpevolmente, non sapevo niente di Umberto Eco. Ma mi incuriosii. Detestando, furiosamente, “Il nome della rosa”, per tutte le volte che le sue pagine mi avevano tagliato le mani, ammaccato, fatto tendere muscoli e mandar giù moccoli, scelsi di Eco un piccolo librino, “Diario minimo”. Chiesi a Orazio se potevo portarmelo a casa, quella sera. Orazio mi disse di sì. Iniziai, da solo, a ridere come un matto leggendo quel libretto. C’era anche una specie di gioco: un kit di istruzioni per fare da sé il proprio film di Michelangelo Antonioni. E anche per farsi un Fellini fatto in casa. O un Visconti.
Umberto Eco mi conquistò quel giorno. Non con un testo studiato all’università. Con un libretto preso dal reparto self della libreria Marzocco. E anche dell’amore per Umberto Eco non mi sarei più liberato. L’anno dopo, sarei andato in treno a Bologna, ogni giovedì, per sentire un’ora di lezione e ritornare a Firenze. Poi avrei letto tutti i suoi libri, mi sarei cibato della sua ironia, della sua curiosità, della sua voglia di giocare con il sapere, ma sempre in modo serissimo. E forse anche tutto questo lo devo a Orazio. Al fatto che mi ha sempre lasciato portare a casa un libro, se glielo chiedevo, e leggerlo la sera, a patto che lo riportassi un paio di giorni dopo.
Li ho sempre riportati tutti, se è questo che vi chiedete. Ma la libreria Marzocco era diventata, oltre che il mio posto di lavoro, anche la mia Grotta delle meraviglie, la Biblioteca di Babele, dove scoprire cose che altrimenti forse non avrei scoperto mai. Come, per esempio, proprio i libri di Borges. Quello che aveva scritto il racconto “La biblioteca di Babele”. E che sapeva raccontare di vertigini in cui la mente umana cadeva, a capofitto, giochi con l’infinito, giochi con l’immensità dell’universo, delle parole, dei destini, del sapere, Borges che per primo mi ha detto che la vita tutta probabilmente è una beffa, o magari un gioco matematico, di cui non ci sarà mai dato sapere la regola.
A volte, anche dopo che avevo smesso di lavorare lì, andavo alla libreria Marzocco per ritrovare Orazio. Per parlare con lui. Per sentire un piccolo tepore di casa. Lì, fra via Martelli e il lungo corridoio pieno di libri tascabili, lì dove c’era la cassa, dove c’era Maria con l’aria sempre scettica, e dove spesso c’era Orazio, sempre in piedi, sempre con qualche libro da mettere a posto, ma sempre con un po’ di tempo per ascoltarti.
Non c’era solo lui, in quella libreria che per me è stata più importante dell’università. C’era Carlo Manzini, al reparto della saggistica letteraria, Carlo Manzini piccolo e assorto, con gli occhiali spessi, con una precisione assoluta nel dirti dove fosse quel volume, e di quale edizione si trattasse, Carlo con una calma quieta e mite, a parlare sottovoce, forse in un dialogo interiore con qualcuno di quei libri. E Massimo Mantelli, che ha gli occhi azzurri e che in quegli anni era bello come gli eroi del cinema poliziottesco, Mark il poliziotto e tutti gli altri. Non c’era una ragazza che non gli cadesse ai piedi, era come Fonzie: e come Fonzie, non aveva bisogno di fare quasi nulla per affascinarla. Oggi Massimo vanta un’amicizia con Fiorella Mannoia che gli invidio molto e una madre ultraottantenne di cui riporta le frasi tranchant, ciniche e verissime, e che ha trasformato – praticamente – in una influencer. L’unica influencer over 80 che io conosca.
Poi c’eravamo noi peones, meno belli, tutti più o meno della stessa età: Marco Mori, con cui entrammo lo stesso giorno di estate torrida del 1983: qualifica? Magazzinieri. Avevamo dei bicipiti come Rocky Balboa, anche se non ci credete. Poi Marco ha fatto carriera, è diventato direttore di quella libreria, si è sposato, non lo vedo da anni ma sono sicuro si sia costruito una solida felicità.
C’era Stefano Rolle, che frequento ancora ogni tanto: Stefano che un giorno vide entrare una nuova commessa, Rossella, con le mani fasciate perché si era bruciata il giorno prima con il forno, con degli splendidi occhi chiari e i capelli ricci. E s’innamorò in dieci minuti, credo. Poi la ha sposata, poi la vita ha fatto il suo corso di onde su onde. Stefano ha messo su una casa editrice, che si chiama “apice”, come il segno tipografico più piccolo. E con quella casa editrice ho fatto il mio primo libro, e ho vissuto la più grande gioia, quando ho visto le copie stampate dentro il bagagliaio della sua auto, un giorno di chissà quanti anni fa. E come sempre, il nostro primo incontro non fu dei migliori. Io, probabilmente, ero lento a sistemare dei libri. Ero sul ballatoio. Lui, da sotto, senza neanche guardarmi mi urlò: “E’ t’ha’ visto un bel mondo, te, va’vai!”. E io ci misi il resto della giornata a decifrare la frase.
C’era Patrizia, che disegnava benissimo, e un giorno su un cartoncino mi lasciò un abbozzo, un occhio e un mezzo viso belli come se l’avesse disegnato Leonardo, giuro che era bellissimo. Per quasi vent’anni l’ho salvato dai traslochi e dal perdersi in qualche cassetto. Poi ho perduto anche quell’occhio e quel mezzo viso.
C’era Carlo François, che conosceva la rivoluzione vera, veniva da Milano, aveva pochi anni più di me ma tanta vita e tanto dolore che io non conoscevo nemmeno. Aveva conosciuto Eugenio Finardi e Mario Camerini, un cantante dell’epoca. Aveva vissuto feste e sconvolgimenti di alcol e sogni rivoluzionari, finiti male. Aveva conosciuto gli anni di piombo e non li aveva soltanto sfiorati, come me, arrivato – per fortuna – troppo tardi per infilarmici dentro. Carlo François che quando andava sul bus guardava sempre fuori dal finestrino, con sovrano disdegno di tutto, perduto anche lui in una sua solitudine. Carlo non c’è più.
C’era Carlo Rao, gentile, riservato, un po’ più grande di me, con cui non riuscivo mai a parlare tanto. Anche lui appassionato di cinema, di libri, di musica. Anche lui non c’è più, da poche settimane. La notizia è arrivata come sempre dentro uno dei messaggini verdi di Whatsapp. Come le migliaia di altri messaggi che non fanno male. Tre o quattro parolette, che ti sembra ancora possibile che non siano vere.
Orazio parlava volentieri anche di musica, musica classica naturalmente. E quindi si finiva a parlare anche di Mozart, Beethoven, Puccini, Verdi. Ma lì mi sentivo troppo ignorante per parlarne a lungo, e quindi non tenevo tanto il discorso. Si tornava a parlare di Nanni Moretti o di Francesco Nuti. Aveva una voce sempre giocosa, Orazio. Meno cantilenata di quella di Paolo Poli, però sempre con una vena di gioco, dentro.
La libreria Marzocco è diventata, negli anni 2000, libreria Martelli. Poi più niente che avesse a che fare con i libri. Ma Orazio l’ho ritrovato: alla libreria Edison, in piazza della Repubblica. È difficile raccontare il piacere che provavo nel rivederlo, lì nella grande agorà, la grande piazza della libreria Edison. Come sentire che c’era una parte di me, che potevo ritrovare nel cuore di Firenze.
Ho avuto pochi amici e pochi padri, nella mia vita. Mio padre l’ho perso quando avevo venticinque anni. Gli altri due padri li ho conosciuti alla libreria Marzocco. Bruno, ruvido scorbutico e buonissimo capo del reparto scolastico. E Orazio. Orazio Borselli, lord inglese nei golfini color pastello. Tutti e due, credo, fedeli al Pci e a un’idea di mondo migliore, che poi non è arrivata mai. Ma tutti e due ci hanno provato, nella loro vita, a rendere più degna la propria e quella degli altri. Tutti e due dediti al lavoro, e rispettosi delle persone.
Bruno, ‘gnorante e baffuto come un narcotrafficante messicano, o come un Renzo Montagnani nella sua forma migliore, se ne è andato qualche anno fa. Orazio Borselli, anima gentile, occhiali rettangolari, amore discreto per il cinema e per i libri, se n’è andato oggi.
L’avevo incrociato qualche mese fa, non era tanto, vicino al ponte delle Cure. Aspettava un autobus, credo. Io ero in scooter, ho frenato, sono tornato indietro, sono rimasto a scambiare qualche parola con lui. Ero felice di averlo rivisto. Sì, un po’ invecchiato, ma il tempo sembrava non avere tirato i suoi pugni peggiori. “Quando finirà questa pandemia verrò a trovarti, Orazio”.
Mi aveva parlato di qualche dolore alla schiena, ma non avevo capito che forse mi stava parlando di qualcosa di grave. Anche lui, maledetta pandemia, non l’ho abbracciato, e non sono andato a trovarlo.
E ora non so più dove trovarlo, se non dentro qualche manciata di ricordi spettinati. E io, come credo tanti altri ragazzi della libreria Marzocco di quegli anni, mi sento davvero molto più solo.

Immagine tratta dal web
- L’invidia - 19 Aprile 2024
- Una morte bianca - 19 Aprile 2024
- Il tempo dei fiordalisi - 19 Aprile 2024