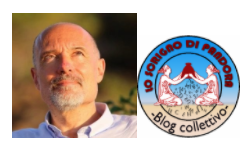
È il pomeriggio dell’ultimo giorno della Mostra. Tutto sta finendo. Mancano poche ore all’annuncio del Leone d’oro. È quell’ora sospesa, per noi giornalisti che ci arrabattiamo fra un film e una conferenza stampa da scrivere subito. C’è il sole, e mi viene la tentazione di andare a Pellestrina, l’isola oblunga che è il prolungamento del Lido, e dove nessuno va mai. Ci si arriva con l’autobus, e c’è un orizzonte piatto bellissimo, un lago d’acqua ferma con gli incroci di assi di legno delle baracche dei pescatori. E più in là, il sole che tramonta sulla laguna, una laguna selvatica, al di là della quale si vedono i Colli euganei.
Sto per andare a prendere l’autobus, l’autobus che si infila in un battello tutto intero, come Giona nella pancia della balena, come Pinocchio. E sbuca fuori di là, in un altro mondo, dove la Mostra del cinema non esiste.
Ma faccio un’altra cosa. Avevo prenotato un biglietto per “Scene da un matrimonio”, la serie televisiva che riprende quella di Bergman, che uscì in televisione a metà degli anni Settanta. Un uomo e una donna, praticamente soli nell’inquadratura, loro e le loro parole, e il loro amore, il loro disamore, le bugie, le liti, le umiliazioni, le cattiverie. La serie degli anni ’70.
Di quella nuova, avevo visto nei giorni passati i primi tre episodi. Al posto di Erland Josephson e Liv Ullman ci sono Oscar Isaac e Jessica Chastain. E, miracolo!, sono altrettanto bravi, sono altrettanto ricchi di quello che vorresti vedere in un attore al cinema: verità, naturalezza, profondità, tensione. Fanno gesti normali, hanno toni di voce normali, oppure alzano la voce, ma solo poche volte. Come noi.
Come nella serie di Bergman, li vediamo all’inizio, immersi in una felicità quieta, inattaccabile. Ma non c’è felicità che non possa avere il suo cancro a minarla, ineluttabilmente. Lui riflessivo, posato, moralista, intellettuale, analitico, serio, ha la barba, gli occhiali, riccioli scomposti, è ebreo, a mezza strada fra Woody Allen e Oliver Sacks. Lei sembra la reincarnazione di “quella” Liv Ullman: stessa pelle, stessa bocca, stessa curva del naso, stessa grazia. È istintiva, sensuale, ambiziosa, inquieta, a volte infantile.
Vedo da capo gli episodi 3 e 4, vedo per la prima volta il quinto e ultimo. In tre ore passano gli anni, la loro relazione si tira e si spezza come un elastico, poi mille volte ritorna, come le onde di un mare che non vuole saperne di abbandonare la sua spiaggia.
È difficile raccontare questo film, non ci sto riuscendo. È un film – una serie, sì: ma è come se fosse un lungo film – che ti dice che due vite, due volti, al cinema, possono essere un’immensità. Ti dice che due vite possono forse bastarsi, ma non possono evitare di farsi del male. Dice che ci rifugiamo dentro boschi di parole, dice che c’è chi soffre in silenzio e prega Dio, quel Dio in cui non aveva mai creduto, che l’altra ritorni. E l’altra crea la frattura nella felicità di entrambi, crea il caos, un caos potente, una ferita irreparabile.
Il resto, sono milioni di parole. Boschi di parole dietro cui nascondersi. O parole che cercano sempre di definire verità nascoste, parole che cercano di analizzare, di capire. Di capire il mistero di due persone che cambiano, anche radicalmente, e non sono mai lì dove te le aspetti.. Capisci quali labirinto sia ogni amore, ogni relazione. Anche la tua, quella che credi di poter definire con una parola: “la mia ragazza”, “il mio compagno”, “fidanzata”, “amico”. È tutto fluido, tutto si muove, tutto attraversa la carne dell’altro.
Per tre ore sono stato a guardare questi due, vicini a pochi centimetri l’uno dall’altra ma incapaci di toccarsi, di stringersi, di tornare una cosa sola. Oppure capaci di farlo, per poi capire che non è cambiato niente. E ogni volta la felicità si trasforma di nuovo in sgomento, mancanza, dolore, nel giro di un attimo. Ogni volta capisci che niente serve a farti stare in equilibrio su quel filo, spinto continuamente dal vento.
Ho visto l’ultimo episodio, ai titoli di coda ho applaudito forte. Mi sono alzato lentamente, mi sono incamminato verso l’uscita. Stavo piangendo, per come siamo tutti, fragili e orgogliosi, votati alla distruzione più che alla costruzione, la costruzione di un amore spezza le vene delle mani, Fossati aveva capito tutto. Ho pianto per quanto abbiamo bisogno sempre dell’altro, e perché non lo troviamo mai. Piango, fra gli occhiali e la mascherina, tanto nessuno mi vede.
E poi, nel buio, ho visto altri due occhi luccicare.
Non ne ero sicuro, ma mi sembrava che ci fosse qualcun altro – in questo pubblico di gente che ne ha visti tanti, di film, e pensa soprattutto a parlarne male, con sufficienza – qualcuno che piangeva.
Ci sono centinaia di persone che escono fuori da un cinema a Venezia, io cammino lentamente, per masticare la mia commozione. Siamo usciti alla luce, fuori dal tendone da circo. È vero: sono lacrime quelle di una persona accanto a me, sulla destra. Lacrime a dirotto, quasi. Siamo appena usciti dal cinema, io non ci vedo bene, ma mi sembra che davvero stia piangendo, tanto. Ma anche lei fa finta di niente, e se ne va da sola verso il prato pieno di roulottes, parcheggiate proprio davanti alla laguna. È bello, questo posto, penso. È come un camping. È tutto verde, e davanti c’è il mare, questo mare-lago color petrolio. Il sole scintilla contro le roulottes.
Si sta allontanando, vedo solo che ha un vestito azzurro completamente aperto sulla schiena, e i capelli biondi, corti. Sarà una straniera.
Non so perché ha pianto. Forse per le stesse ragioni mie, forse perché ha vissuto momenti simili nella sua vita, amori che sono finiti, la voglia di farli ricominciare, il dolore di vedere che ciò che è rotto non si accomoda facilmente. Non lo saprò mai, perché piangeva.
Cammino un po’ verso quell’acqua che mi affascina sempre. E a un tratto la vedo accanto, alla mia destra. Con gli occhi lucidi. E allora le dico la cosa più stupida che mi viene in mente: “Did you like the movie?”. Ma lei sorride. Mi risponde in italiano, con accento straniero.
Non le chiedo perché piangeva. Non lo saprò mai. Cerco di dirle perché quel film mi ha commosso tanto, le dico che avevo visto la serie originale, quella svedese, in televisione quando ero bambino. Sembra venire dalla Scandinavia, o lì vicino. “Where are you from?”. Un’altra domanda stupida. A questo punto potrebbe dirmi che ha da fare e deve andare subito.
Mi dice, invece, che è americana. È venuta in Italia per fare un film. Da regista. Un film da girare in Liguria. O forse ho capito male. Le chiedo se sia anche un’attrice. Sì, mi dice. Ma senza enfasi, come se non fosse una cosa tanto speciale.
Vorrei parlarle ancora, come nel film che abbiamo appena visto, ciascuno in un pianeta separato. Vorrei sapere più cose, vorrei arrivare a capire perché un’attrice, che di film ne ha visti tanti, sia riuscita ad emozionarsi, a vivere quello che accadeva sullo schermo.
Allora il cinema serve ancora a qualcosa, non solo alle chiacchiere di chi la sa lunga, di chi la sa così lunga che ormai non si meraviglia più, non ama più, ma sta solo a criticare, a giudicare, a disprezzare, a sminuire. E invece un film è il risultato di un miracolo, ogni volta. Un artigianato prezioso, e miracoloso.
Vorrei stare a parlare ma tra poco inizia la premiazione. E io devo seguirla, devo scrivere immediatamente dopo, fino a tardi. E per vedere “Scene da un matrimonio” non mi sono preparato sui film che potrebbero vincere il Leone d’oro. Ho solo pochi minuti, prima che cominci la premiazione, e devo farmi trovare pronto, con il computer aperto. Forse, penso, potrei seguirla anche da lì, sulla riva della laguna, seduto sull’erba col computer sulle ginocchia, oppure offrirle un caffè alla Riva di Corinto. Ma no, non mi posso distrarre proprio adesso, all’ultimo giro, rischiare di fare un lavoro schifoso, impreciso, di mettere nei guai il mio capo e me stesso. Non posso prendermi questa ora, questo caffè, queste parole.
18:45. Alle 19 la premiazione inizia. Facciamo due passi sull’erba, le chiedo perché sia venuta in Italia.
E la risposta è la più impensabile, la più improbabile, la più incredibile, la più pazzesca che poteva darmi.
“Sono venuta in Italia perché amo il calcio, vado pazza per il calcio”, mi dice in italiano. “E perché sono tifosa della Fiorentina”.
A questo punto temo di essere come Anthony Hopkins in “The Father”. Vedo persone che non esistono nella realtà. La Fiorentina? Un’americana che si commuove allo stesso film che vedo io, con cui per un caso rarissimo riesco a parlare, e che tifa Fiorentina? Lei non sa che sono di Firenze, che da quando avevo sei anni tifo viola.
Forse è una persona straordinariamente empatica, che entra in sintonia in maniera misteriosa con gli altri. Forse mi dice che tifa Fiorentina perché ha letto la mia anima, in qualche modo. Forse ha la password dei miei pensieri, e per empatia, prima, piangeva. Forse non esiste, me la sto immaginando io.
La luce del tramonto sull’acqua, sulle baracche in mezzo alla laguna, sull’erba è come una canzone. È la luce più bella di tutta la giornata, in uno dei posti più belli del Lido. E allora, per convincermi che lei sia reale, e non una proiezione dei miei pensieri, un ologramma visibile solo a me, le chiedo di scattarle una foto. Sapendo che può reagire male. Sono un tizio che ha conosciuto due minuti prima.
E invece mi dice “sì”, con gli occhi che le sorridono.
Così, ecco qui questa foto. Un attimo diverso, una scheggia della Mostra in cui non ho seguito il percorso obbligato delle ore e dei minuti, un momento in cui sono andato fuori dalla strada obbligata. Ecco la foto, gliela mostro, è contenta. Me ne vado, ho solo dieci minuti prima che cominci la cerimonia, mi incammino, non la vedrò mai più.
#raccontidivita# #raccontionline# #raccontibrevi# #donne# #Venezia# #incontrispeciali# #cercandodite#
- Ricordo - 25 Aprile 2024
- Filastrocca dei colori diversi - 25 Aprile 2024
- Futuro e passato - 25 Aprile 2024