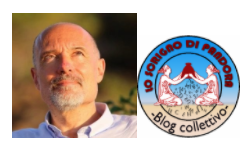
Quel gesto. Quel gesto di toccarsi il sopracciglio, per un attimo. Toccarsi il sopracciglio con l’indice della mano, abbassando un po’ la testa. Come per un pensiero improvviso, come chinando la testa per modestia. Quel gesto. Che imponeva un piccolo “stop” alla narrazione, che metteva in pausa tutto il resto. Quel gesto, tipico di Massimo Troisi.
Quel gesto, quasi musicale: uno “stoppato” che Massimo Troisi ripete, nei suoi film, quando è in imbarazzo, quando sta per dire qualcosa di grande, quando la situazione lo sta mettendo in crisi. Quel gesto che non ha nessun altro attore. Come i mille microscopici segni dell’alfabeto dei gesti di Massimo Troisi.
Mario Martone, nel film che ha dedicato all’attore e regista napoletano, è andato a ricercarli, quei momenti. Ha messo insieme una, due, dieci volte in cui Troisi si tocca il sopracciglio, in un film. E li ha montati, insieme al montatore Jacopo Quadri. È solo un piccolo esempio della cura, dell’attenzione con cui Martone ha costruito “Laggiù qualcuno mi ama”, il documentario su Massimo Troisi che esce nelle sale giovedì 23.
Chi sia stato Troisi, per chi ha la mia età, non c’è bisogno di spiegarlo. Una rivoluzione dolce, un modo di ridere diverso. Un passo verso il futuro, improvviso e definitivo, dopo che Napoli era stata Eduardo, Peppino e Totò. Lui, Massimo, era differente: un napoletano che non esagerava, che non esibiva niente, che tendeva quasi a sparire, invece che a mostrarsi. Imprevedibile e complesso come gli accordi sulla chitarra del suo amico Pino Daniele.
Chi sia stato Troisi, anzi: chi sia, per sempre, ogni volta che si guarda un suo film, lo spiega il film a chi era troppo giovane per essere investito, agli inizi degli anni ’80, dalla sua sommessa rivoluzione. Mario Martone ci dà almeno tre cose che non conoscevamo.
La prima: ci fa scoprire Anna Pavignano, la donna con cui Massimo ha scritto tutti i suoi primi film. Anche per me, spettatore superficiale, da ragazzo, era sempre stato un po’ misterioso quel nome di donna accanto a quello di Troisi, nei titoli di testa, alla voce “film scritto da”. Anna Pavignano è piemontese, ha gli occhi chiari, la voce nitida, la logica garbata e razionale.
Capisci che i film di Troisi, il suo modo di raccontare l’amore, quel modo così diverso, così moderno, con l’uomo che non si vergogna di mostrarsi fragile, insicuro, vulnerabile, con le donne forti, che non si tengono dentro niente, che discutono, che fanno le loro scelte, beh: quel modo di raccontare l’amore viene da loro due, dall’incontro delle loro culture, delle loro personalità, delle loro storie politiche e personali. Per pensare a Troisi bisogna ricominciare da tre: e uno dei tre punti è Anna Pavignano.
Il secondo regalo che Martone ci fa, nel film, è mostrarci i fogliettini scritti a mano da Troisi. Non sono idee da film: sono piuttosto riflessioni sulla vita, considerazioni, poesie. Si vede la sua grafia fluida e quasi femminile: una grafia che diventa scomposta e quasi illeggibile nei diari dei giorni della sua prima operazione al cuore, a New York.
“Dolori lancinanti”, “incubi”, “incubi” le parole ricorrenti, scritte senza riuscire a dominare la grafia. E poi, dopo l’operazione, il disegno di un cuore bucato e poi ricucito, e la parola “riesco!”. Con accanto la precisazione: “non nel senso di ‘riuscire’, ma di tornare a andare fuori dalla stanza d’ospedale”.
O qualcosa del genere. Anche nel momento più drammatico, al primo giocare a testa o croce con la vita e la morte, Troisi non perdeva l’abitudine di vedere il lato comico della cosa.
Il terzo regalo è una sequenza. Che Martone prende dal finale di uno dei film di Troisi, “Pensavo fosse amore, invece era un calesse”. Non spoilero: chi ha visto il film, la ricorderà.
Ma ti basta vedere quella sequenza per capire che Troisi non era soltanto un attore, era un regista raffinato, sempre più maturo: che aveva imparato da Ettore Scola: quanto dei carrelli che attraversano i decenni nel film “La famiglia” di Scola c’è in quell’ultima sequenza di “Pensavo fosse amore”.
E fa bruciare l’anima pensare che quella sia anche l’ultima sequenza del Troisi regista. Poi, sarà solo il volto scavato del Troisi attore nel “Postino”, sarà quella casa con le pareti rosa a Salina, che simula Capri dove trovò rifugio Pablo Neruda.
Poi, è solo la testimonianza di Roberto Perpignani, montatore di quel film, che sembra ancora non capacitarsi: “Venerdì è venuto, ha girato tutta la sua parte, comprese delle voci che mancavano, aveva finito tutta la sua parte. E nel fine settimana mi hanno telefonato dicendomi che era morto”. Però, nel racconto che fa, Perpignani lascia cadere, come di passaggio, una frase che gela il sangue: “Giravamo, e accanto al set c’era sempre l’ambulanza”.
Era come se dicesse che la morte stava aspettando, paziente, che Troisi finisse il film. Quella morte su cui, con la sua grafia minuta, in frasi scritte con la penna Bic su un quaderno ingiallito, Troisi si interrogava. In una poesia, mette insieme “a ciorta” e “a morte”, la fortuna e la morte: la seconda è certa, la fortuna invece può arrivare anche troppo tardi.
Per lui, ragazzo di San Giorgio a Cremano, ragazzo fragile da sempre, figlio della piccola borghesia – “sì, ma con sei fratelli siamo scesi di grado, da piccola borghesia siamo diventati un po’ meno”, dice in un’intervista tv – per lui, dicevamo, la sorte è arrivata intorno ai trent’anni, con il successo immenso che gli arrivò con “Ricomincio da tre”.
Un successo che raccontava una cosa sola: tanti ragazzi si riconoscevano in lui, in quelle esitazioni, in quelle paure. Tanti ragazzi si sentivano voglia di toccarsi il sopracciglio, e voltare lo sguardo da un’altra parte, come faceva lui.

Immagine tratta dal web
- Senza cuore - 3 Maggio 2024
- Camminiamo insieme - 3 Maggio 2024
- Prima che piova - 3 Maggio 2024