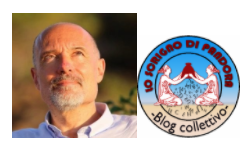
Ci passo sempre, con lo scooter.
Ci passo sempre davanti, davanti a quel cancello.
Lì, in quella strada lunga che da una parte tocca casa mia, e dall’altra la biblioteca nella quale vado a studiare, a scrivere.
Quella strada dritta che sta fra i quartieri popolari, stradine che sembrano di paesi, e – dall’altra parte – l’inizio delle colline, la salita verso il verde. Si potrebbe anche dire, verso l’Appennino.
E insomma, lì c’è quel cancello. E dietro, la mia scuola elementare.
Ci sono passato un milione di volte. Poi qualche settimana fa l’ho visto aperto. E allora, per un impulso strano, mentre qualche mamma ritardataria usciva con i figli, sono entrato, con lo scooter.
Ho fatto la salita, nel verde. E arrivato in cima, ho parcheggiato sulla ghiaia, cercando di non far rumore. Sentendomi un intruso.
Era metà pomeriggio. Nel grande parco, tutto era uguale al 1970. O almeno, così mi sembrava. Gli alberi, i sassi della ghiaia, quel panorama su Firenze, la chiesa. Sotto, mi ricordo, c’era il cineforum, dove vidi forse i primi film della mia vita.
Non sapevo perché ero lì. Sapevo che c’era una parte della mia vita, lì. Ma non sapevo come – anche solo lontanamente – trovarla.
Ho visto una piccola suora china su una pianta in vaso. Toglieva delle erbacce. “Scusi…”, dico, senza sapere ancora che cosa dire. Ma in un attimo vedo qualcosa di familiare in quella figura, in quel volto. “Suor Laura…?”. Non mi sembra possibile di ricordare una persona, dopo quasi sessant’anni. “Sono Giovanni, ero da voi all’asilo e alle elementari”. “Ma certo. Non eri tu che aspettavi il pulmino insieme a quell’altro bambino, Paolo Falciani?”.
Non riesco a crederci. Io l’ho riconosciuta, lei mi ha riconosciuto. E di colpo sessant’anni si cancellano, in un istante.
Suor Laura non era stata fra le mie maestre, né all’asilo né alle elementari. Aveva altre classi, o altre mansioni. Però me la ricordavo, forse più della suora che ci ha fatto lezione per cinque anni. C’era, quando io facevo l’asilo, in quel luogo fuori dal tempo, in cui ho avuto la fortuna di vivere, in molte delle prime mattine della mia vita.
Quando andavo all’asilo, lei aveva trent’anni. Era giovane, così giovane. Era il 1966, il 1967, il 1968. Gli anni dell’Alluvione, della guerra in Vietnam, della contestazione a Parigi. Niente di tutto questo faceva sentire il suo rumore lì, in quei parchi sotto gli ippocastani, in quel piccolo villaggio di Asterix. Da dove si vedeva, da una terrazza, tutta Firenze.
“Suor Laura…?”. “Sì, sono suor Laura”. L’avevo riconosciuta subito. Avevo visto, in lei, la suora trentenne con il neo nero su una guancia, il sorriso comprensivo e accogliente, le sopracciglia nere, e certo anche i capelli neri, sotto il velo.
E poi parlammo di una cosa che era impossibile che ricordassimo entrambi. Un giorno, era un giorno di sole, avevo quattro o cinque anni. E i bambini fanno tante schifezze: uccidono le formiche, danno baci alle compagne d’asilo, scandalizzando le suore. Oppure, come feci quel giorno di sole, potevano giocare con quello strano liquido che usciva dal naso. Non era mica una cosa “sporca”: era una cosa curiosa, che usciva dal naso. E il bambino che ero a quattro anni ci giocava. E glielo feci vedere, suor Laura. Lei mi sgridò, com’era normale. Si mostrò schifata da quella cosa. E io, da qualche parte dentro di me, pensai qualcosa tipo “pensavo che lei fosse più comprensiva delle altre”. Poi quell’episodio me lo sono dimenticato.
Beh. Quando parlammo, quel pomeriggio, dopo pochi minuti, suor Laura, mi hai detto: “Giovanni. Devo dirti una cosa. Un giorno, ti rimproverai perché avevi le dita tutte piene di moccio. Ma era stata un’altra suora a ordinarmi di rimproverarti: e io lo feci, per obbedienza. Ma mi dispiacque così tanto: perché sentivo di aver tradito la tua fiducia in me. Ci ho pensato così tante volte”. E mi venne un groppo in gola.
Come hai fatto, suor Laura, a ricordarti questo insignificante episodio per sessant’anni? Come hai fatto a tirarlo fuori dalla nebbia di sessant’anni? Come hai potuto avere la modestia di sentirti in colpa, per aver tradito la fiducia di un bambino? Che poi avevo accettato quel rimprovero, ci ero solo rimasto un po’ male. “L’altra suora insisteva che io fossi dura con te, ma a me dispiacque così tanto. Tu ti fidavi di me, e io non me lo sono mai perdonato”.
Quando me ne andai, ti regalai una copia del libro che ho scritto su mia mamma, e che mi ero portato dietro per regalarlo alla biblioteca dell’Orticoltura.
Mi dicesti che eri serena. “Ho ottantasette anni, sono serena. Anzi, sono un po’ impaziente di andare”, mi dicesti. Mi ringraziasti molto per quel libro, e tornasti a curare le piante.
Alla fine di agosto, mi scrivesti. Su Whatsapp. Mai e poi mai avrei immaginato che potessi padroneggiare una cosa così moderna come Whatsapp. “Sto leggendo il tuo libro, lo leggo e lo rileggo. Mi piace e la tua mamma mi è entrata nel cuore”.
Dovevo andare alla Mostra del cinema di Venezia. Appena torno passo, pensai. Poi mille cose, tutte pressanti, tutte da fare di corsa. È passato un mese. In realtà non so mai quando passare: non so quali sono gli orari, i ritmi, i rituali, le abitudini, gli obblighi di una religiosa. Temo sempre sia il momento sbagliato. Vengo da te il 10 ottobre. È un pomeriggio ancora assolato. Salgo su, con lo scooter. Parcheggio negli stessi centimetri dell’altra volta, sulla ghiaia, davanti a dove ho visto i primi film della mia vita, il film su Bernadette e quello, straziante, sul bambino che moriva, dopo aver ricevuto tanti regali di Natale.
Mi aspettavi. Andammo nel parlatorio, un po’ tetro. Mi dicesti che eri nata nel 1937, nel Valdarno, vicino a Bucine, mi pare. Il padre socialista, la madre cattolica. Avevi sei anni quando ci fu l’armistizio, non potevi ricordarti. Ma ti ricordavi di quando eri adolescente, e ti piaceva studiare. Ma un giorno dopo l’altro, ti eri convinta in maniera perfetta, e inespugnabile, che quel Dio c’era e ti aspettava. Che avresti vissuto tutta la vita per lui. Ti chiesi come era accaduto. “Non ci fu un momento preciso, ma una certezza che piano piano si manifestò in me”. Parlavi con grande proprietà, sceglievi sempre le parole con cura. E le dicevi, con quella voce calma.
Dal parlatorio ci dovemmo spostare, un’altra suora aveva un appuntamento con qualcuno, evidentemente qualcosa di importante. Andammo in un altro edificio, un’altra stanza nella quale c’era un pianoforte. Pensai che mi sarebbe piaciuto farti sentire qualche nota, forse una canzone.
Mi offristi dei succhi di frutta, portasti un piccolo vassoio con due succhi di gusti diversi, e un bicchiere. Ma non avevo sete. Volevo parlare con te. Volevo ritrovare qualcosa dei miei anni, di quegli anni perduti in una tasca fonda della vita.
Avevi letto il libro, e non te ne eri scandalizzata. “Il tuo libro mi piace, mi diverte e mi fa sentire vicino a te e alla tua mamma”, mi hai scritto. Ti aveva fatto ridere la pagina in cui parlavo del “ragazzo di mia nonna”: l’uomo che a settant’anni era andato a presentarsi a mia nonna, vedova da vent’anni, per dirle che lui la amava da mezzo secolo, in silenzio. E prendersi uno scampolo di vita insieme a lei. Furono felici, tutti e due. E tu non ci trovasti niente di strano, niente di scandaloso. Erano riusciti a essere felici. Ti avevano fatto ridere, quelle pagine.
La luce che entrava dalle finestre ti dava fastidio, preferivi la penombra. Mi parlasti delle altre suore. Quelle che non ci sono più, quelle che ci sono ancora, in altre “case” in giro per la Toscana. Mi hai raccontato che anche voi andate in vacanza: vi alternate, d’estate, in una casa che avete al passo della Consuma, fra i boschi, dove fa fresco. Vi ho immaginato a fare passeggiate fra gli abeti, e godere di quella semplicità. Anche il passo della Consuma è più o meno immutabile.
Anche adesso hai i sandali, senza calze. Chissà quante volte hai avuto freddo. Oppure il fisico si abitua a certe sofferenze. Parlo con te con un po’ di timore, come se questa conversazione potesse essere sgradita alle altre suore, come se potesse dare scandalo.
Ti chiedo di come si siano riverberati, lì dentro, i grandi eventi che hanno scosso la storia. L’alluvione di Firenze, il terrorismo, il rapimento di Aldo Moro, le contestazioni degli studenti. Ma sembri non averli visti, non averli conosciuti. “Sai, Giovanni, qui noi vediamo i bambini. E i bambini sono sempre gli stessi. Ti mantengono giovane, ti fanno sentire giovane. Certo, abbiamo imparato che le famiglie non durano. Ci sono tanti bambini di genitori separati: e ogni tanto, qualcuno se ne va, perché la madre va via, in un’altra città, e non lo vediamo più. Per me è sempre un grande dolore”, mi dicesti.
Uso il passato remoto, ma è dieci giorni fa. Dieci giorni.
Ti ricordavi dell’altro bambino, Paolo Falciani. Che aspettava con me, la mattina alle otto, che passasse il pulmino, quello che ci avrebbe portati a scuola. Il pulmino puzzava quasi sempre del vomito dei bambini del giro che ci aveva preceduto. Era tremendo entrare, ma si entrava. E poi c’era suor Maura sempre allegra, che ci cantava “Bella ciao” a squarciagola. E il pulmino passava da via Ragazzi del 99. Io ero piccolo, ma capivo che voleva dire “ragazzi nati nel 1899”. E mi chiedevo: ma come fanno a essere ragazzi, se sono nati così tanto tempo fa?
Quello che non sapevi erano le conversazioni che facevamo, con Paolo, mentre nella nebbia d’inverno aspettavamo il pulmino. Parlavamo dello smog, dell’inquinamento, chissà dove avevamo imparato quelle parole. E c’erano pochi tubi di scappamento, poche auto, molta nebbia. Ma noi a discutere dell’avvelenamento del pianeta, come due Greta Thunberg con mezzo secolo di anticipo.
Mi parli di un istituto che gestite, da qualche parte in Toscana. E dentro ci sono dei pazienti psichiatrici. “Uno è stato condannato per omicidio, ma non si ricorda nulla”, dici. E lo dici con pietà, con benevolenza. Anche lui va aiutato, anche lui va tenuto per mano.
“No, non ho mai sentito come una costrizione stare qui. E poi, come vedi, andiamo fuori, nelle altre ‘case’. E poi abbiamo i bambini. Come possiamo essere tristi?”. Hai avuto tanti bambini. E non li hai mai giudicati. Come non hai mai giudicato me. Né quando ero bambino: né adesso, leggendo questo libro che è pieno di spigoli, di filo spinato, di bordi taglienti, di schegge di vetro, di dolore, di urla, di ruggine, di disperazione. E non puoi non essertene accorta.
Quando mi sono alzato per salutare, mi hai detto, quasi leggendomi nel pensiero: “Puoi girare per il parco quanto vuoi! Puoi stare tutto il tempo che vuoi”. Me lo hai detto con gioia, come se ti fosse venuto in mente che cosa regalarmi. Ed era vero, era un regalo. Potermi riappropriare, per un momento, di quel parco, di quel giardino, guardare i ricci caduti dagli ippocastani.
Ti chiesi se avevate delle fotografie, se fosse possibile ritrovare le foto della nostra classe. “Certo, ci devono essere”. Magari la prossima volta le cerchiamo insieme, dissi.
Andandomene via, ho guardato il pianoforte verticale nella stanza. “Ma qualcuno suona?”. “Certo”, mi hai detto. E ho pensato che effettivamente si canta, si canta tanto nei conventi, nei monasteri, nelle chiese. E allora ti ho detto che ti avrei mandato una canzone, un modo che ho trovato per parlare di mia mamma.
Domenica mi hai scritto: “Mi piace ascoltare e riascoltare la canzone delle formiche… Ci sei tutto, c’è l’animo di fanciullo che hai. Ti sono vicina”.
A ottantasette anni, dopo settant’anni di convento, puoi ascoltare su YouTube una canzone scritta da uno che ascolta De Gregori e Le luci della centrale elettrica, pensai. Allora sei ancora giovane.
Oggi pomeriggio mi è squillato il telefono. Credevo fosse il corriere Brt, ero stato fino a quel momento al telefono con il risponditore automatico, digitando numeri su numeri. Invece era suor Annarita, la madre superiora. Chissà come aveva avuto il mio numero. Dapprima ho pensato che mi sgridasse, perché avevo parlato con una suora, o perché le avevo regalato un libro non conforme ai canoni ecclesiastici. Per una frazione di secondo, mi sono difeso così. Poi ho capito, senza voler capire. Continuando a dire “no”, come se mi avessero ingannato, ancora una volta, su Dio e sul destino.
Dicono che ti sei accasciata nel viale delle rose, quella specie di tunnel coperto da rami di rose, quella galleria verde.
E ora non c’è più nessuno che sappia chi sono stato, quando ero bambino, quando ero una goccia di infinito.
Dicevi di attendere la morte “con una certa impazienza”. Dicevi di essere sicura che sarebbe stato bellissimo, di là. È arrivato, quel momento. Chissà se davvero è bellissimo, di là. Qui è brutto, adesso. Aspetto ancora il pulmino, ma sono solo.

Immagine tratta da Pixabay
- La bellezza dei fiori selvatici - 29 Aprile 2024
- Amori - 29 Aprile 2024
- Stanislas Lépine, L’église Saint Samson à Ouistreham en Normandie - 29 Aprile 2024