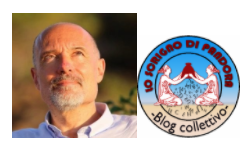
Ero a uno dei primi festival della mia vita. Avevo pochi anni davvero. Al momento di restituirmi il documento, il portiere dell’albergo me ne dette uno sbagliato. Peter Bogdanovich, c’era scritto.
Mi venne da ridere, e fui tentato per un attimo di tenermelo.
Bogdanovich, morto oggi a ottantadue anni, dopo una vita di cinema, di film ma anche di studio e amore per il cinema, dopo amori piuttosto drammatici nella vita reale, aveva un cognome che mi aveva reso subito curioso di lui.
“Bog”, del resto, nelle lingue slave – lui, figlio di un serbo ortodosso – vuol dire “Dio”. E allora probabilmente tutti noi Bog-qualcosa del mondo siamo, in origine, come i “Diotallevi”, “”Diotaiuti”, “De Dominicis”, “Degl’Innocenti” o “Eco”, ex caelo oblatus. Tutti venuti giù dal cielo, figli di Dio i cui antenati sono stati lasciati da qualche parte davanti a una chiesa.
Caro Bogdanovich, hai avuto una vita tutta di cinema. Ti eri innamorato del cinema prima di farlo: organizzando rassegne dei tuoi registi amati, Hitchcock, Orson Welles, Howard Hawks. E mica in un posto qualunque, ma al MoMA di New York.
Aveva venticinque anni, Bogdanovich, quando organizzava le rassegne lì, come facevano a Parigi quelli della Nouvelle vague, critici cinematografici prima di essere registi. Poi le cose si sono mescolate in fretta. E così è diventato, quasi tutto insieme, regista, produttore, critico cinematografico, documentarista.
Aveva poco più di trent’anni quando, nel 1971, andò a intervistare John Ford, il più grande regista di film western, e ne trasse il documentario “Diretto da John Ford”. Il vecchio regista di western rispondeva laconico e brutale al giovane fan: risposte secche, infastidite, da parte della leggenda scorbutica.
Ma nel frattempo, Bogdanovich era già diventato famoso. Aveva diretto un film da regista, “L’ultimo spettacolo”: un bianco e nero diventato presto “cult”, che ottenne otto nomination all’Oscar. Nel 1972 rievoca le atmosfere della commedia sofisticata con “Ma papà ti manda sola?”, con Barbra Sreisand e Ryan O’Neal. E diventa ancora più “cult” con il film successivo, del 1973: “Paper Moon”.
Ambientato negli anni della Grande Depressione, filmato in un bianco e nero stupendo da Làszlò Kovàcs, interpretato da Ryan O’Neal e dalla sua vera figlia Tatum, che per quell’interpretazione vince l’Oscar, è uno dei film più belli e delicati degli anni ’70. Vedendolo, Wim Wenders ebbe voglia di rinunciare al film che stava girando, “Alice nelle città”, che trattava ugualmente di un adulto e di una ragazzina. Per fortuna, anche Wenders portò a termine il suo – bellissimo – film.
Andava tutto a gonfie vele per Bogdanovich: troppo. S’innamorò dell’attrice Cybill Shepherd, ruppe il suo matrimonio con la scenografa Polly Platt, che gli aveva dato due figlie. E Hollywood non glielo perdonò.
Peggio ancora quando nel 1980 s’innamorò di Dortoy Stratten, una playmate di “Playboy”, che fu uccisa dal marito geloso, il quale poi si tolse la vita. Otto anni dopo, Bogdanovich sposò Louise Beatrice Stratten, sorella di Dorothy. Non proprio il miglior biglietto da visita per un’America ancora puritana.
La sua carriera prosegue altalenante, con due picchi. La prova da attore, nel ruolo dello psicoterapeuta nella serie “I Sopranos”. E il prezioso lavoro per riportare alla luce il film-summa sul cinema, mai terminato da Orson Welles, “The Other Side of the Wind”, girato negli anni ’70, ma completato – grazie al suo aiuto – solo nel 2018, quando fu presentato fuori concorso alla Mostra del cinema di Venezia.

Immagine tratta dal web
- Juan Gris, Ritratto di Picasso - 26 Aprile 2024
- Cambiamenti e scuse - 26 Aprile 2024
- Umanità dormiente - 26 Aprile 2024