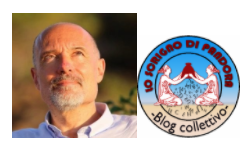
Non ti ho mai detto neanche della Pensione Romagnola.
La Pensione Romagnola era a Torino, dove andavo per trovare la ragazza dai capelli di ametista, che ancora non aveva una casa lì, e faceva su e giù da un paesino di provincia in mezzo alla nebbia.
E allora cercai una pensione che costasse poco. Non poco, pochissimo. Era in centro, forse vicino a via principe Amedeo. Tutti i palazzi erano grandi e grigi.
Per arrivare alla pensione si salivano tre piani di scale a piedi, niente ascensore. L’uomo della pensione Romagnola aveva i capelli rossi, ed era siciliano.
Entrai nella stanza, mi misi a dormire. L’indomani avrei visto la ragazza della mia vita. Mi avrebbe parlato delle poesie che leggeva, mi avrebbe insegnato le canzoni dei cantautori che io non conoscevo, mi avrebbe guardato e io sarei partito verso i confini dell’universo…
Nel buio, entrò nella stanza qualcuno.
Un uomo.
Erano le tre di notte.
Accesi la luce. “Chi sei? CHI SEI?”. Tremavo.
Lui, con una voce irritata, disse “Questa è mia stanza”. Era “anche”la sua stanza, in effetti.
Non mi aveva detto, l’uomo della pensione Romagnola, che la stanza che avevo pagato non era una singola, ma una doppia “assortita”.
L’uomo era tunisino. Si chiamava Yamal. Era venuto a Torino per cercare lavoro. “C’è molto lavoro, qui a Torino. Altri miei amici spacciano, ma io voglio lavorare” mi disse, prima di voltarsi su un fianco e spegnere la luce.
Al mattino, il gestore della pensione Romagnola mi disse, in un italiano molto meno comprensibile di quello del mio compagno di stanza: “Sei qui per la ragazza? Attento. Che le torinesi sono poche serie, u capisti? Entrano nei portoni insieme ai ragazzi, e…”. Non ti fidare, mi disse.
Uscii nel gelo della Città della nebbia, intirizzito e confuso. E pensai alle torinesi che si stavano stringendo con dei ragazzi, dentro gli altri portoni.
Ventinove lire
Fra un mese è il tuo compleanno, mamma, e io ancora non ho finito questa specie di libro su di te. E vorrei dirti: resta con me ancora un attimo, per favore. Perché vorrei metterci dentro tutto, tutti i ricordi e anche tutto quello che tu non hai visto, e che avresti dovuto vedere.
Perché vorrei fare di questo libretto una fotografia del mondo, del mondo che era e del mondo che è: quello che tutti i libri vorrebbero essere. E perché vorrei stare ancora, in qualche modo, con te.
Anche se stai scappando via, sempre di più, anche se adesso la tua presenza è diventata leggera leggera, un soffio, un’ombra. Lo vedi che non riesco più a ricordare che poche cose che ti riguardano.
Vedo la tua ricrescita di capelli bianchi sotto i capelli tinti di castano chiaro, vedo le tue mani con la pelle fine fine e con le macchie di vecchiaia, vedo i tuoi biglietti, i tuoi appunti con una grafia incerta ma ancora volitiva, fragile ma non vinta; vedo il tuo cappottino leggero color avorio, una specie di giubbino che mettevi sopra il maglione, sempre troppo largo.
E così uscivi fuori. Ti vedo che esci dall’ascensore, quando ti aspetto sotto, a casa tua, per portarti in macchina da qualche parte, quelle rare volte che siamo riusciti ad andare da qualche parte, che poi erano sempre pochi chilometri.
Vedo te che gonfi le guance quando ti rimprovero o ti spiego qualcosa, e gonfi anche gli occhi per dirmi “ma che palle!” ed è come se tu diventassi la bambina e io il professore.
Vedo la tua macchia scura, allo zigomo sinistro, che ti era venuta in vecchiaia, una specie di verruca brutta a vedersi. Vedo la luce strana dei tuoi occhi, dopo che ti eri fatta l’operazione della cataratta, come se tu avessi dentro gli occhi due pezzettini di vetro scintillanti.
Vedo quando ti levavi la dentiera, e sembravi di colpo più vecchia di dieci anni, solo gengive e un paio di denti, come gli anziani veri, quelli delle case di riposo. Tu non eri così, tu rispondevi a tono al telefono, e ragionavi ancora dritto.
Ti sbagliavi solo con gli euro e le lire: quanto è costato questo maglione che mi hai comprato, mamma? “Ma che tu vòi sapere, è costato icché ll’è costato, che te ne frega?”. “Dai, mamma, dimmelo, che non posso portarlo, se è costato tanto”. “Mah… ma è costato… mi pare ventinove… Ventinove lire… No, ventinovemila euro… Insomma t’hai capito!”.
No, che non ho capito. Non ho capito che cosa ti avrebbe fatto piacere, non ho capito come aiutarti, e certo non ho capito quanto male poteva farti una cattiva parola, un gesto di rabbia, di stizza, di disamore.
Quel colpo sul muro della cucina, quando mi dicesti: “Io ti ho dato una casa”, mentre avrei voluto attenzione, rispetto, incoraggiamento, fiducia, pace, gioia. Tutto quello che non ti ho dato , in realtà.
- Juan Gris, Ritratto di Picasso - 26 Aprile 2024
- Cambiamenti e scuse - 26 Aprile 2024
- Umanità dormiente - 26 Aprile 2024