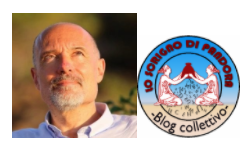
Lusevera
Non c’è solo questo nome mancato e misterioso, Selene, nome che sarebbe dovuto essere mio, nome che affondava nel buio dello spazio. C’è una piccola storia che ho sempre trascurato. Il fatto che non dovevo nascere.
Il 3 maggio 1963, giorno che oggi sembra seppellito nel tempo, sono venuto al mondo. I Beatles non erano ancora famosi, c’erano John Kennedy e papa Giovanni: sarebbero morti tutti e due quell’anno. L’anno in cui Martin Luther King pronunciava il discorso “I Have a Dream”. Tu, mamma, queste cose non le sai. Sì, sapevi che c’era un papa “buono”, forse di Kennedy sapevi che aveva una moglie che si chiamava Jacqueline. In quel 1963 sapevi, soprattutto, che qualcosa di imprevedibile stava cambiando, velocemente, la tua vita.
Sono nato nove mesi e un pugno di giorni dopo il vostro matrimonio. Stavate ancora chiedendovi se l’avreste voluta, una cosina urlante e cacante in mezzo alle vostre vite, per sempre. Un esserino che avrebbe cambiato la tua vita ordinata, mamma, e la tua vita precaria di rappresentante di medicinali appena tornato dall’Africa, papà. Ve lo stavate chiedendo, e io ero già lì.
Non ho mai saputo dove sono stato concepito. Ma dev’essere stato in una pensione/baita di quel minuscolo paese il cui nome aveva per te qualcosa di mitico, mamma: Lusevera. Lì faceste, credo, la luna di miele. Ci arrivaste chissà come, con la Seicento di papà, e chissà perché. Un paese pieno di erba, di fiorellini e di boschi tutto intorno, verso le Dolomiti, non lontano dal confine con la Slovenia. Scopro adesso che, lì vicino, c’era un paesino chiamato Caporetto. E chissà se non fu una Caporetto rovinosa anche la mia nascita.
Da Caporetto, i soldati italiani corse giù, all’impazzata, sconfitti, terrorizzati, inseguiti, insubordinati, disertando, ammassandosi sui ponti. E la gente di Lusevera e degli altri paesini in fuga, anche loro, lasciando le case così com’erano, o aspettando che austriaci, boemi e tedeschi calpestassero quei fiorellini e le loro donne. Ma voi, chissà perché, finisce a Lusevera, e a te mamma quel posto dava tanta pace, ti sembrava un paradiso. Era l’estate del 1962, dopo il vostro matrimonio, il 22 luglio 1962, il giorno del compleanno di papà. Compiva trentacinque anni. Nel mezzo del cammin di sua vita, avrà pensato. Non era così: gli restavano venticinque anni, e di felicità forse solo i primi quattro o cinque.
Ventunmila giorni fa
In un ospedale fiorentino, nove mesi e undici giorni dopo il vostro matrimonio, il 3 maggio 1963, chissà com’era il tempo. Era un venerdì, erano gli anni del baby boom, che non era ancora una brutta parola. Erano le speranze di tanti che portavano all’euforia, a pensare che c’era vita in abbondanza, che era bello creare la vita.
Quel giorno era un venerdì, di ventunmila giorni fa. Ventumila giorni. C’è una canzone di Vasco Brondi che dice che abbiamo ventiseimila giorni. In ogni caso, la maggior parte dei giorni per me è passata. Ad oggi, mi dice una pagina sul web, sono vivo da 511mila ore, e da 30 milioni di minuti. Cinquecentomila ore. Buttate via in vario modo. Mezzo milione di ore. Sono tante, sono poche?
Nelle prime di quelle cinquecentomila ore, lì in quell’ospedale, su una collina sopra Careggi, le cose non andarono benissimo. “Avevi il cordone ombelicale avvolto tre volte intorno al collo”, mi dicevi sempre. E io non ci ho mai fatto molto caso, visto che in qualche modo dovevo essermelo scrollato di dosso. “Ti misero nell’incubatrice”, e anche in questo caso non mi sono mai preoccupato molto. In qualche modo dovevo essere uscito anche da lì. Ma se mi hanno messo nell’incubatrice, significava che non respiravo da solo. Che non ce l’avrei fatta, all’aria aperta, con la temperatura normale del mondo. Voleva dire che senza quella scatolina trasparente con dei buchi tondi per metterci le mani delle infermiere forse non sarei sopravvissuto. Non sarei qui a scrivere, oggi. Sarei in un mondo scuro e denso, un mondo che non conosciamo: il mondo delle vite che non esistono, il mondo dei destini mai iniziati,
Papà non era andato al lavoro, quel giorno. Aveva il naso incollato sul vetro del reparto maternità. Papà che, quando pioveva, diceva “passo tra goccia e goccia”, papà che alla domanda “come stai?” rispondeva sempre “benone!”, anche pochi giorni prima di morire. Papà che non ho mai visto piangere, quella volta piangeva. Per la paura che finisse tutto in una bolla di sapone, che non riuscissi a venire al mondo, che nascessi e morissi nel giro di poche ore, che me ne andassi via dalla vostra vita. Avrei dovuto pensarci più spesso, che mentre il cordone ombelicale mi strozzava, e mi tiravano al mondo col forcipe senza per fortuna schiacciarmi il cervello, tu mi amavi già, e già soffrivi per me,e pensavi a che immenso disastro sarebbe stato, se fossi nato morto. Tu che non avevi paura di nulla, neppure della tua morte, avevi paura della mia. Avrei voluto vederti, papà, e credere così al tuo amore.

Immagine tratta dal web
- Juan Gris, Ritratto di Picasso - 26 Aprile 2024
- Cambiamenti e scuse - 26 Aprile 2024
- Umanità dormiente - 26 Aprile 2024