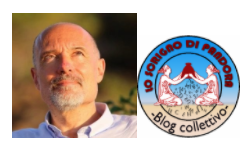
Era bionda, aveva gli occhi chiari, e si chiamava Monica.
Aveva i capelli sottili, e aveva quattro anni, come me.
Seconda asilo. Io nella fila di destra della classe, lei dal lato opposto, dove forse c’era una grande finestra da cui veniva la luce, come nei quadri di Vermeer.
La luce bella della mattina, forse era primavera. Certo il sole entrava dalla grande finestra.
Nessuno, oggi, può ricordare quel momento, può conoscere quel piccolo, minuscolo, insignificante gesto nell’immenso brulicare dei gesti e degli attimi vissuti dall’umanità. Nessuno lo può ricordare, quel momento semplice, quella cosa da nulla. E io, naturalmente, non te ne ho parlato mai.
Solo io posso ricordarlo, finché vivo. Quel giorno, mentre la luce illuminava tutti e si posava, Monica, sui tuoi capelli biondi, mi alzai – passai davanti alla suora che stava spiegando qualcosa. Andai da te, primo banco a sinistra. E ti baciai.
Poi tornai tranquillo al mio posto. Avevo fatto una cosa buona, un piccolo gesto di amore. Mi stupì molto sentire la suora molto, molto, molto irritata. Stetti zitto, ma dentro me pensavo “ma perché mai?”.
Dopo l’asilo tornavamo sempre a casa con quel pulmino, una Seicento Multipla color caffellatte, che sembrava un pesce, senza muso, ma con gli occhi tondi spalancati. Quel pulmino che ci metteva mezz’ora per depositarci ciascuno davanti alle nostre case, distanti pochi metri dalla scuola. In quel tragitto parlavamo, come due attori di un film hollywoodiano. E io ti tenevo la mano. In quel pulmino che puzzava sempre di vomito: nel giro precedente, c’era sempre qualche bambino che non ce l’aveva fatta…
Il pulmino si fermava davanti a casa tua, quella casa che ancora oggi sa di anni ’60, davanti a quel cinema che esiste ancora, come tutta questa periferia un tempo così radiosa, così “nuova”. Chissà di cosa riuscivamo a parlare, a quattro anni. Ma mi sentivo bene, e ti salutavo sereno, sicuro che la vita non avesse sorprese. Che ti avrei rivisto il giorno dopo.
Quando mi chiedevano che cosa volevo fare da grande, rispondevo “l’astronauta”. E le ragazze rispondevano, spesso, “la hostess”. Sulla strada in discesa, sotto casa tua, c’era un distributore di chewing gum. Con cinque lire, giravi una manopola e veniva fuori una pallina gommosa, dolce, tutta colorata. Tutto sembrava giusto.
I cento passi
Chissà com’è stato possibile che nessuno abbia voluto farcela pagare. Che nessuno, fra gli altri bambini, si sia accorto di quello strano guscio invisibile nel quale riuscivamo a rinchiuderci, per qualche minuto, quando tornavamo a casa in quel pulmino dall’odore nauseabondo.
Chissà com’è stato possibile che nessuno, grembiuli neri e fiocco azzurro, abbia cercato di punirci per quella specie di felicità. E chissà da dove avevo preso quell’arte di darti un bacio come se fosse stata la cosa più semplice e più bella del mondo.
Da papà, l’avevo preso. Sicuramente imitavo il gesto che doveva fare con te, mamma. Quando, diceva, “gli scappava” di darti un bacio. E d’improvviso, per nessun motivo al mondo, ti baciava con i gesti e la semplicità di un bambino di quattro anni. Non era ancora arrivato il momento in cui ti saresti ritratta, con qualche scusa flebile, “devo cucinare”, “brucia la pizza nel forno”, perché tu, papà, eri diventato fragile e imbarazzante come Henri Toulouse-Lautrec in quel film degli anni ’50 che ti piaceva tanto, mamma. Il pittore sfortunato, l’artista punito dal destino.
Niente più baci, in casa nostra. E niente più baci neanche a Monica. Venne la prima elementare, nella nuova classe tu non c’eri. Era il corso naturale delle cose, il pulsare della vita che diveniva, che formava le nuove figure del suo caleidoscopio. E andava bene così. Ma sono sicuro, sono sempre stato sicuro che quello è stato il mio primo amore, e il più sereno. Non lo hai mai saputo, mamma, così come non hai mai saputo degli altri.
È pazzesco, ci sono solo cento passi fra le nostre due case. Una volta, una sola – anni fa – mi sono fermato davanti al tuo portone, Monica. C’erano ancora tutti i campanelli di ottone, tutte le targhette. All’ultimo piano, c’era ancora scritto il tuo cognome. Non ho suonato, non ho chiesto di te.
Eppure, qualcuno probabilmente sapeva, ti conosceva, poteva dirmi qualche frammento della tua storia, che non si è più incrociata con la mia, nonostante abbiamo vissuto ancora, per anni, nelle stesse strade.
Ho avuto paura. Paura di suonare al campanello di quella bambina e di veder scendere quasi una nonna, di veder correre gli anni tutti insieme in un nanosecondo, come l’astronauta di “2001 odissea nello spazio” dopo che ha fatto il suo viaggio oltre l’infinito, e si ritrova vecchissimo.
O, peggio ancora, ho avuto paura di saperti sparita nel buio, come l’altro astronauta, quello che – tagliato il filo con l’astronave – volava via.
- Juan Gris, Ritratto di Picasso - 26 Aprile 2024
- Cambiamenti e scuse - 26 Aprile 2024
- Umanità dormiente - 26 Aprile 2024